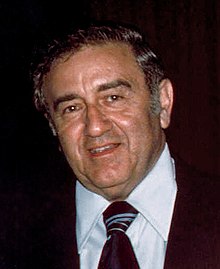È il momento. Siamo arrivati inesorabilmente alla fine dell'anno. Spero che in questo 2021, sicuramente migliore dell'anno precedente, abbiate avuto la possibilità di andare al cinema il più spesso possibile, se pur con mascherine, distanziamenti e amenità varie. Io sicuramente non mi sono fatto mettere i bastoni fra le ruote e, tra un litigio con i trasgressori delle regole anti Covid e una discussione con chi teneva il telefono acceso con l'illuminazione al massimo, ho visto senza dubbio molta più roba rispetto all'anno scorso (quando tra l'altro dei pochi film che ero riuscito a vedere in sala me ne saranno piaciuti cinque...).
Comunque, come ogni testata, pagina o blog di cinema che si rispetti, anch'io ho deciso di stilare una lista dei film migliori del 2021, o quantomeno dei film che io ho preferito tra quelli usciti in quest'anno solare. Come d'obbligo, alcune precisazioni per pararmi il culo: se non trovate qualche titolo che secondo voi meriterebbe un posto in questa lista, considerate la possibilità che non mi sia piaciuto quanto a voi o, molto semplicemente, non l'abbia visto. Del resto, se avessi il tempo e il denaro per vedere ogni singola pellicola in sala penso che lo farei, senza contare il fatto che titoli molto attesi come Ultima notte a Soho e Annette nella mia città non sono proprio arrivati...
Per cui, anticipando subito che non troverete l'ultimo Spider-Man, direi di non perdere altro tempo e iniziare. In ordine allegramente sparso, questi sono i film che ho apprezzato di più nel 2021:
Nomadland
di Chloé Zhao
Partiamo con un film uscito nell'anno solare 2020, ma arrivato in Italia solo a fine aprile e non in sala grazie a una fantastica scelta di distribuzione (grazie, Disney). Il film vincitore del Leone d'Oro alla mostra di Venezia è stato uno dei film commerciali più politici dell'anno, e sotto questa luce il fatto che si sia aggiudicato tre premi Oscar, tra cui quello al miglior film, appare forse meno sorprendente di quanto si potrebbe pensare. La pellicola tratta un tema molto serio e socialmente rilevante, ma non lo fa in tono polemico, focalizzandosi più sulle implicazioni esistenziali di una situazione ai limiti del disumano che coinvolge molti, troppi lavoratori. La condanna al capitalismo rimane sullo sfondo di quella che è soprattutto un'opera contemplativa, in cui la collettività è più importante di quella che sarebbe la protagonista (una Frances McDormand meritatamente premiata con il suo terzo Oscar), anche perché l'ottima regia sceglie di esaltare soprattutto le splendide ambientazioni, con campi lunghi e lunghissimi che fanno sembrare i personaggi umani quasi delle formiche in balìa del mondo. Perché in fondo è questo che sono i piccoli dipendenti per le multinazionali: formiche che devono produrre, fino a quando non si fanno più soldi. Dopodiché, li attende la vita fuori dal formicaio, costretti a lottare per sopravvivere.
Tutto ciò, unito a una magnifica colonna sonora del maestro Ludovico Einaudi, riserva a questo film un posto tra i migliori dell'anno, assurdo per me se penso che quest'anno la stessa Zhao sia stata anche dietro la macchina da presa di Eternals, film Marvel talmente anonimo che potrebbe tranquillamente averlo diretto mio cugino.
Rifkin's Festival di Woody Allen
Altro film uscito a fine 2020, ma arrivato in ritardo in Italia a causa della pandemia, è l'ennesimo ottimo film di uno dei più grandi maestri della commedia mondiale, che nonostante l'ormai veneranda età continua a dimostrare una lucidità senza pari. Con Rifkin's Festival Allen si diverte come un ragazzo, ribadendo sì gli stessi temi che propone da oltre 50 anni, ma rappresentandoli con una freschezza e una brillantezza che risulterebbero sorprendenti anche per un giovinastro. Il protagonista Mort Rifkin (Wallace Shawn) si aggiunge alla folta schiera di “cloni” caratteriali dell'autore, vagando (letteralmente) tra incertezze coniugali, blocchi dello scrittore e crisi esistenziali e trovando (forse) la salvezza nella figura di una dottoressa spagnola interpretata dalla bellissima Elena Anaya, che sono molto contento di aver ritrovato dopo averla apprezzata in quel capolavoro di La pelle che abito del monumentale Pedro Almodòvar.
Con un rinfrescante guizzo di creatività, Allen sceglie di dare forma alla psiche dell'insicuro Mort attraverso quello che sia lui che lo stesso regista amano di più: il grande cinema. La regia si fa magnificamente camaleontica nel replicare perfettamente alcune scene dai capolavori di Fellini, Godard, Welles e, ovviamente, Bergman. E da fan sfegatato delle opere di Allen non appena ho visto quel finale, tributo al grande maestro svedese e allo stesso tempo autocitazione ad uno dei primi e più grandi capolavori del maestro di New York, non ho potuto non sorridere pensando: “Buon vecchio zio Woody, l'hai fatto ancora”.
A Classic Horror Story di Roberto De Feo e Paolo Strippoli
Primo film italiano della lista, e sono felice di dire che non sarà l'ultimo. Quando si dice nomen omen: Paolo Strippoli e Roberto De Feo (già responsabile dell'ottimo The Nest, a mio parere superiore) ci regalano appunto una classica storia horror, una divertente rilettura di alcuni stilemi del genere filtrate da un'ambientazione geo-culturale tutta italiana. Un film a basso costo che non tradisce assolutamente la sua natura economica, e in cui gli autori si rivelano in grado di citare tanto Shining quanto Midsommar, con un comparto tecnico-visivo assolutamente all'altezza e una buona dose di meta-cinema a farla da padrone. La maggior parte degli attori, poi, se la cava più che bene, a partire dalla bravissima Matilda Lutz, già protagonista di Revenge, e perfino la piccola Alida Baldari Calabria, che sicuramente conoscerete come la Fata Turchina del Pinocchio di Matteo Garrone.
Insomma, un esperimento di genere che mi ha molto divertito, e che pertanto, nonostante le numerose critiche che l'hanno stroncato, reputo meritevole di un posto in questa lista. Mi dispiace solo di non poter includere un altro horror italiano uscito quest'anno, Il mostro della cripta, che purtroppo mi ha convinto solo in parte e che ho trovato maldestro in alcuni punti. Detto ciò, entrambi questi titoli non possono che far bene al nostro cinema, sperando davvero che possano contribuire a una rinascita del genere in questo Paese.
Luca di Enrico Casarosa
Purtroppo, l'unico film d'animazione di quest'anno che mi ha veramente colpito. Pur avendo apprezzato la Disney con il suo Encanto (decisamente meno con Raya e l'ultimo drago), è la Pixar ad averla vinta, con uno dei suoi lavori più spensierati degli ultimi anni. Luca non è né una straordinaria avventura in mondi fantastici, né una profonda esplorazione dell'animo umano, ma semplicemente una deliziosa parentesi estiva, una storia di amicizia e accettazione del diverso narrata attraverso un McGuffin: i due bambini protagonisti, Luca e Alberto, sono dei mostri marini, che cambiano in forma umana sulla terraferma e si ritrasformano a contatto con l'acqua. Il litorale costiero della Liguria, terra natale del regista Enrico Casarosa, e gli anni '60 sono il pittoresco sfondo di questa piccola fiaba moderna, che nasconde un tema molto importante sotto la candida semplicità tipica dell'infanzia.
Personaggi simpaticissimi, ambientazioni suggestive, uno stile visivo unico mai visto prima nei lavori della Pixar e una colonna sonora meravigliosa che va ad includere anche noti brani pop italiani rendono questo film una gioia per gli occhi, le orecchie e il cuore, e Casarosa, al suo primo lungometraggio dopo il poetico corto La luna, manda un sentito messaggio d'amore per il suo Paese, con uno spirito più vicino a quello di un'opera di Fellini o dello Studio Ghibli che alla convenzione disneyana, tanto che persino il nome del paesino, Portorosso, è a solo una lettera di distanza da Porco Rosso, il capolavoro di Hayao Mityazaki anch'esso ambientato in Italia e anch'esso felliniano nell'animo. Una coincidenza? Mi piace pensare che non sia così.
Dunque, anche se mi mancano ancora alcuni titoli come Belle di Mamoru Hosoda, la Pixar vince anche quest'anno sul fronte animazione.
Dune di Deins Villeneuve
Quest'anno l'aspetto blockbuster si è rivelato piuttosto deludente dal mio punto di vista, con solo due titoli ad entrare tra i miei preferiti dell'anno. In mezzo al solito casino di supereroi, remake Disney e Fast & Furious (aiuto), l'evento dell'anno è stato senza dubbio Dune, prima parte della trasposizione del monumentale ciclo fantascientifico di Frank Herbert. Si tratta di una delle opere più importanti della letteratura di fantascienza, considerata per molto tempo, un po' come Il Signore degli Anelli, praticamente impossibile da portare sullo schermo. Già autori del calibro di David Lynch e Alejandro Jodorowsky hanno tentato l'impresa in passato, il primo riuscendoci in parte (colpa della produzione), il secondo non riuscendoci affatto.
Il buon Denis Villeneuve, però, non è nuovo ai miracoli di questo tipo, essendo riuscito a tirare fuori un degno sequel di Blade Runner a 35 anni dall'originale, e con Dune si porta a casa l'ennesimo film della Madonna. Stiamo parlando di un vero e proprio colossal, con effetti speciali allo stato dell'arte, un nutrito cast stellare e milioni e milioni spesi per un film che, a causa della pandemia e dei piani della Warner con HBO Max, rischiava di mancare la sala. Fortunatamente in sala ci è andato, ed ha anche incassato bene. E lasciatemelo dire, da parte di qualcuno che ha amato il libro, Villeneuve ha fatto davvero un lavorone. Il film è una space opera che non solo rende giustizia agli scritti originali (anche se si parla solo della prima parte del libro), ma riesce ad elevare l'epica della narrazione con una messa in scena davvero paurosa: gli effetti non sono sovrabbondanti, bensì sono al servizio dell'opera, il casting è azzeccatissimo, regia, montaggio e fotografia sono roba dell'altro mondo... e poi ci sono le musiche.
Hans Zimmer firma alcune delle sue composizioni migliori, una mole di lavoro tale da coprire ben tre album e per la quale il musicista ha rifiutato di lavorare a Tenet, diretto dall'amico Christopher Nolan.
Insomma, pur avendo una natura seriale e nonostante non mi senta di considerarlo al pari di altre opere di Villeneuve, da grande amante della fantascienza “impegnata” non potevo non apprezzare questo incredibile risultato, un film che, come tutte le prove migliori del regista canadese, riesce ad essere d'intrattenimento quanto profondo, senza annoiare mai nonostante le due ore e mezza di durata. Non vedo l'ora di vedere la parte 2 che uscirà nel 2023.
The Suicide Squad di James Gunn
Secondo e ultimo blockbuster, in assoluto il film che mi ha più divertito quest'anno. Solo uno come James Gunn poteva resuscitare dalle ceneri qualcosa di abominevole come il Suicide Squad del 2016, uno dei peggiori film che abbia visto in vita mia.
La DC (o meglio, la Warner), pur mirando chiaramente agli incassi, fa la scelta più azzeccata affidando all'uomo dietro il successo dei due Guardiani della Galassia la regia di questo sequel/soft reboot: il risultato è un film più violento, più divertente, con migliori effetti, migliori musiche, migliore scrittura, miglior regia, miglior TUTTO.
A differenza di Ayer, Gunn regala uno spettacolo di altissimo livello, girando un grande omaggio al cinema d'exploitation realizzato però con un budget milionario, e il suo stile, che resta intatto, si adatta perfettamente a questi personaggi, a cui finalmente viene resa giustizia e che finalmente risultano simpatici (Harley Quinn in primis), a tratti addirittura drammatici.
Lo scontro finale con un alieno stella marina di dodici piani parla chiaro: potrai togliere un regista alla Troma, ma non toglierai mai la Troma a un regista. Meravigliosamente trash.
The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson
Ritorniamo al cinema d'autore, con uno dei miei registi preferiti in assoluto. Wes Anderson, a mio parere, non ne sbaglia una, e la sua ultima fatica, presentata a Cannes, non fa eccezione. Questo sublime omaggio al mondo del giornalismo è un tipico film di Wes Anderson, frase questa che si presta a diverse interpretazioni, a seconda della sensibilità di ognuno: per alcuni si tratta di un'opera manieristica di un autore ormai intrappolato nei suoi stessi cliché, per altri, me compreso, il tipico film di Wes Anderson vuole dire gioia visiva, un tripudio di colore (quando il colore c'è), inventiva, sperimentazione tecnica e tematiche alte passate attraverso un velo di bizzarria e apparente ingenuità.
Per quanto mi riguarda, non ci troviamo davanti a uno dei migliori film del regista texano, ma si tratta comunque dell'ennesima dimostrazione della perizia e della poesia che quest'uomo riesce sempre a sprigionare, magari anche a costo di ripetersi o disorientare.
È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino
Restando fra i grandi autori ma tornando in Italia, non potevo non includere È stata la mano di Dio, senza dubbio il film più personale di uno degli artisti più acclamati del nostro Paese.
Sorrentino
gira un po' il suo Amarcord
offrendo uno spaccato della Napoli anni '80 dal punto di vista di una
famiglia come tante, che trova nell'arrivo di Maradona in città una
speranza. Sebbene
non manchino i classici momenti in cui ogni inquadratura sembra
urlare “sono il nuovo Fellini!”, il regista riesce comunque a
rimanere sobrio quando serve, descrivendo con veridicità e un tocco
di poesia una realtà che conosce molto bene.
Servillo
è grandioso come sempre e il giovane Filippo Scotti si è
decisamente guadagnato il premio Mastroianni come miglior attore
emergente alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Ma anche gli
altri interpreti non sono da meno, in particolare una Luisa Ranieri
che ha praticamente “David di Donatello alla miglior attrice non
protagonista” stampato in fronte.
Pur non entrando nella top 5 dei suoi film, È stata la mano di Dio è il migliore di Sorrentino da dieci anni a questa parte, ed è un vero peccato che si sia potuto godere la sala per solo un mese prima di finire relegato su Netflix.
The Last Duel di Ridley Scott
Senza dubbio il film più sottovalutato di questa lista, considerando che si è rivelato un enorme fallimento al box-office e non se ne sente parlare in giro quanto si meriterebbe.
Per quanto mi riguarda, se le catastrofiche recensioni di House of Gucci dovessero rivelarsi fondate non sarebbe una tragedia, considerando che per quest'anno Ridley Scott ha dimostrato di essere in piena forma con The Last Duel: con il pretesto di raccontare l'avvenimento storico dell'ultimo “duello di Dio”, avvenuto nel 1386, la splendida sceneggiatura di Matt Damon e Ben Affleck (!) fa un illuminante discorso sul concetto di stupro e consenso, ponendo al centro di tutto la figura di una donna vittima (o almeno così pare) della violenza di un mondo patriarcale che vedeva il sesso femminile come un bene da usare ed esporre piuttosto che come un essere umano con una dignità. Un mondo che mi piacerebbe pensare sia molto cambiato in 600 anni, se non fosse che i discorsi al limite del delirante che sentiamo uscire dalla bocca dei personaggi di Matt Damon e Adam Driver suonano spaventosamente simili ad alcuni che ho sentito realmente con le mie orecchie. È un film crudo, girato da Scott con una maestria innegabile e che, tralasciando un Ben Affleck totalmente fuori parte, vanta interpretazioni di altissimo livello, in particolare quella di Jodie Comer, che detto francamente è materiale da Oscar.
Troppo passato in sordina, ma del resto non c'è da stupirsi, considerando che è disponibile su Disney+ già a due mesi dell'uscita nelle sale...
Diabolik
dei Manetti bros.
Prima parlavamo di un possibile ritorno del genere in Italia, e un altro film che mi fa ben sperare è l'ultima fatica dei Manetti, uscito da una settimana e che, non ve lo ripeterò mai abbastanza, dovete andare a vedere, perché una roba del genere NON DEVE fare flop.
Diabolik è un cinefumetto riuscito praticamente in tutto, un esercizio di stile pop e divertente con il quale i registi riescono a rendere giustizia a uno dei fumetti più amati della storia del nostro Paese, oltre che a citare addirittura il grande Mario Bava con scelte di regia e fotografia veramente grandiose a tratti figlie del film cult del 1968. Dalla sceneggiatura giocosa ai personaggi, dalle interpretazioni (Miriam Leone a parte) all'aspetto tecnico, tutto funziona alla stragrande nel replicare lo stile e l'atmosfera degli anni '60, periodo in cui il rivoluzionario fumetto delle sorelle Giussani iniziò la pubblicazione. L'unica pecca è forse il finale, non a livello narrativo ma per la messa in scena da pubblicità del profumo, sembrava che dovesse partire Parlami d'amore, Mariù da un momento all'altro.
Per il resto, è un film sostanzialmente perfetto per ciò che vuole essere: un film d'intrattenimento, realizzato con tutti i crismi e che mi ha pure fatto venire voglia di rispolverare la mia collezione di fumetti di Diabolik.
Una scommessa assolutamente riuscita, che spero vivamente risulti vincente anche dal punto di vista economico.
Dunque, questi sono i film che mi hanno più colpito in questo 2021 ormai quasi finito.
Cosa ne pensate? Quali sono i film che avete preferito quest'anno? Fatemelo sapere con un commento.
Io vi ringrazio per aver letto e vi auguro di passare un felice Natale e un anno nuovo di gran lunga migliore di quello appena trascorso. Ciao!